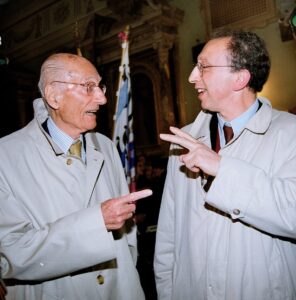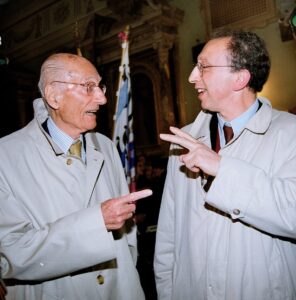
Domande e risposte.
Trascrizione a cura di Alessandro Rosati
Domanda: per quanto riguarda il rapporto tra vero, verosimile e giornalismo. Citando Montanelli lei ha detto “meglio raccontare la verità con aneddoti falsi”, ma la domanda sorge spontanea: così facendo non si esce dal campo del giornalismo?
Alberto Malvolti: Giustamente tu applichi al giornalismo una definizione classica, per cui il giornalismo è semplicemente un racconto distaccato e obiettivo dei fatti. Certamente questa operazione di introduzione di elementi narrativi nella scrittura giornalistica è un passo abbastanza audace da parte di Montanelli. Però funziona. Funziona perché nessuno dei soggetti raccontati da Montanelli, come personaggi, si è mai lamentato che la sua personalità era stata tradita dal racconto. La personalità è risultata vera anche se c’erano degli aneddoti “di colore”. Il verosimile è stato una verità, meglio di un realismo puro e semplice che non diceva molto del personaggio. Proviamo a fare una riflessione su tre termini: verità, vero e verosimile.
Se io dico “vero” intendo quello che è accaduto, un fatto vero. Se faccio un ritratto di una persona rendendola verosimile, posso sia “tradire” quella persona e raccontare il falso, sia raccontare una verità. Si può descrivere qualcosa con elementi che non fanno parte del “vero”, ma che attraverso il “verosimile” rendono un ritratto di “verità”.
La risposta che Montanelli ha dato ad Emilio Cecchi è la più eloquente per questa domanda: con tanti “pezzetti” di verità, a seconda di come sono disposti, si può costruire un ritratto completamente falso. Un po’ come un collage di pezzi di foto con cui puoi fornire un’immagine diversa. Un ritratto di un grande pittore invece può estrapolare di più da una persona, rispetto ad una fotografia con un sorriso stereotipato, fatto giusto per essere fotografati. Tirare fuori la verità richiede spesso e volentieri una buona dose di verosimile: il collage (di pezzetti di verità, ndr) da solo non è sufficiente, anzi a volte può servire per raccontare delle “mega” bugie. Tra l’altro non è un caso che Montanelli esprima questo concetto proprio a Cecchi, uomo di grande spessore che sapeva di avere la stessa linea di pensiero.
Domanda: Una domanda che probabilmente ha già affrontato: sotto tutti i punti di vista, cosa vuol dire essere un giornalista?
Alberto Malvolti: Probabilmente se lo chiedete a 10 giornalisti, avrete 10 risposte diverse. Tra l’altro quello che penso io ha anche poca importanza, perché io non sono un giornalista e non frequento redazioni di giornali. Sono abbastanza sprovveduto da questo punto di vista. Essere giornalista al tempo di Montanelli, nella sua concezione, era quella di essere un testimone: vedere e poi raccontare i fatti. Questa potrebbe essere una definizione di quel ramo particolare del giornalismo che si chiama reportage. Montanelli è stato famoso negli anni’ 30/40 per il reportage di guerra e poi di viaggio (in Giappone, in America, In Africa ecc). È anche vero che oggi questa forma giornalistica, non dico che è tramontata, però è in un ambito molto limitato. Il modo di procurarsi le notizie ormai passa attraverso agenzie di stampa, internet ecc. L’individuo, il giornalista in persona, è passato in seconda linea rispetto al flusso di notizie che viaggia attraverso altri canali. Quindi il giornalista non ha più la figura di protagonista che aveva un tempo.
Vi voglio leggere una particolare definizione che diede proprio Montanelli. Alla domanda “sopravviveranno il giornali di carta?”, Montanelli rispondeva così: “Penso di sì. Il quotidiano tradizionale è un’invenzione a suo modo perfetta: si piega, si trasporta, si legge si butta. I quotidiani come li conosciamo diventeranno però (era il 1999, il mondo è ulteriormente cambiato) l’abitudine di una minoranza ancora più ristretta di quella attuale. Il motivo? La concorrenza. Sessant’anni fa, quando ero inviato speciale, l’Italia aspettava i miei articoli per sapere cosa stava accadendo in Finlandia. Oggi qualsiasi avvenimento è coperto, come si dice in gergo, da televisioni, radio, quotidiani nazionali e locali, agenzie, settimanali, mensili, internet e quant’altro. Questo bombardamento di informazioni equivale spesso a nessuna informazione. Vuole sapere se sono amareggiato? No, sono rassegnato. Ho l’impressione che i quotidiani diventeranno un segno di distinzione, come i libri, i congiuntivi e le posate d’argento. Verranno molto copiati, molto citati, ma letti poco. Alcune informazioni specializzate arriveranno da internet, se ho capito cos’è, non mi stupirei quindi se l’offerta di questi media, sempre a caccia di grandi numeri, scendesse ancora di livello”. Diagnosi abbastanza pessimista, come si vede, anche troppo. Il vecchio Montanelli tendeva ad inclinare verso il pessimismo. È chiaro che nel vedersi cambiare il mestiere tra le mani avesse questo tono pessimistico.