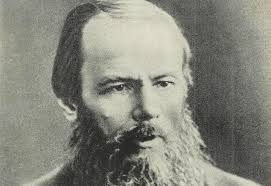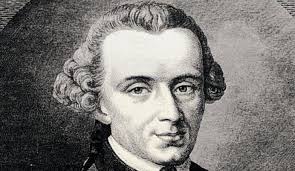di Alissa Piconcelli
Roland Barthes è uno scrittore, critico letterario e saggista francese (1915-1980). Tra le opere più importanti ricordiamo Il grado zero della scrittura (1953), Miti d’oggi (1957) e La camera chiusa (1980). Frammenti di un discorso amoroso fu pubblicato nel 1977 con l’intento di rappresentare un manuale per gli innamorati. Al suo interno si trovano molti riferimenti ad altri libri di altri autori, come I dolori del giovane Werther di Goethe, il Simposio di Platone, riferimenti a Nietzsche e Freud. Barthes sostiene che l’amore si manifesti attraverso il linguaggio e di conseguenza la caratteristica principale dell’innamorato è quella di parlare di continuo del sentimento che prova ma il linguaggio non può afferrare un sentimento del genere e ciò fa risultare il modo di esprimersi insufficiente.
Barthes prende in esame delle parole che fanno riferimento alla sfera amorosa e le commenta, aggiungendo riferimenti agli altri autori. Uno spazio particolarmente notevole è dedicato – dato che si parla di amore era inevitabile – al Simposio di Platone.
Questo brano parla del vestiario del soggetto e del modo in cui si prepara per vedere il suo amato:
“Socrate: <<mi sono fatto bello, per andare bello da un bello.>> Io devo rassomigliare a chi amo. Io postulo (ed è questo ciò che mi delizia) una conformità di essenza fra l’altro e me. Immagine, imitazione: faccio il miglior numero possibile di cose come l’altro. Io voglio essere l’altro, voglio che lui sia me, come se noi fossimo uniti, rinchiusi nel medesimo sacco di pelle, giacché il vestito non è altro che il liscio involucro di quella materia coalescente di cui il mio Immaginario amoroso è fatto”. La parola di questo capitolo è abito, che ha il compito di suscitare un ricordo o un’emozione tramite la ricordanza del vestito indossato dal soggetto in occasione dell’incontro amoroso per sedurre l’amato. Socrate si era preparato per andare a cena a casa di Agatone, invitato a celebrare una vittoria. A chi non è mai capitato di vestirsi bene per un’occasione importante, come un appuntamento con la persona che ci piace? L’atto di curare la propria immagine è istintiva poiché si tende ad “entrare nell’occhio” di colui che ci piace e se si riesce nell’impresa, il fatto di vestirsi bene diverrà un’azione automatica.
Leggi tutto “Ronad Barthes e l’amore ai tempi del Simposio”